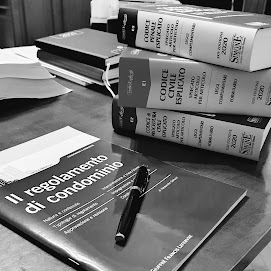GUASTO ALL’IMPIANTO ELETTRICO DI CASA
CHI PAGA TRA INQUILINO E PROPRIETARIO?
Quando si
verifica un guasto all’impianto elettrico di casa, chi deve pagare la
riparazione tra l’inquilino e il proprietario di casa?
La risposta
non è univoca e occorre distinguere caso per caso.
Partendo dal
dato normativo, l’art. 1575 c.c. dispone che il
locatore (il proprietario di casa) deve consegnare al conduttore (l’inquilino)
l’appartamento in buono stato di manutenzione, deve mantenerlo in stato tale da
servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento.
Da questa
norma si può già offrire una prima risposta: se il malfunzionamento
dell’impianto elettrico è preesistente al contratto di
locazione, le relative spese sono esclusivamente a carico del
proprietario, dal momento che è obbligo di quest’ultimo di mettere
a disposizione dell’inquilino un appartamento in buono stato di manutenzione e
in condizioni idonee ad essere utilizzato.
Inoltre, non
possono essere imputate all’inquilino spese per riparazioni rispetto a danni
che si sono verificati in dipendenza di un precedente rapporto locatizio.
Pertanto,
prima di sottoscrivere il contratto, sarà buona regola che il conduttore
verifichi anche il corretto funzionamento dell’impianto elettrico e, se del
caso, segnalare subito e per iscritto (affinché ne resti traccia) al
proprietario eventuali malfunzionamenti.
Allo stesso
modo, se l’impianto elettrico non è a norma perché vetusto, le spese di
adeguamento alla normativa vigente saranno ad esclusivo carico del
proprietario.
A parte questi
due casi pratici che possono verificarsi prima che si dia esecuzione al
contratto di locazione, per il resto vale la regola generale dettata dagli artt.
1576 e 1609 c.c., stanti i quali il locatore (proprietario
di casa) deve eseguire in corso di locazione tutte le riparazioni necessarie,
ad eccezione della piccola manutenzione dovuta all’usura che resta in carico al
conduttore (inquilino).
Ne segue che
rientrano nella gestione ordinaria dell’immobile le piccole riparazioni
(sostituzione dei punti luce, delle lampadine, delle pulsantiere, delle prese
elettriche e dei segnalatori acustici) che sono conseguenza dell’usura e che
per tale motivo sono a carico dell’inquilino, mentre gli interventi
straordinari (sostituzione del quadro elettrico generale piuttosto che la
sostituzione di tutto l’impianto elettrico di casa) spettano al proprietario.
A quest’ultimo riguardo si segnala la seguente sentenza: “in tema di
locazione di immobili, gli artt. 1576 e 1609 c.c. pongono a carico
del conduttore l'obbligo di eseguire le riparazioni di piccola manutenzione;
quelle relative agli impianti interni all'immobile (ad esempio elettrico,
idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento
non rientrano, come tali, nelle riparazioni dette, restando a carico del
locatore tutti gli interventi necessari per ricondurre l'immobile locato in
buono stato locativo; in particolare la riparazione degli infissi esterni
dell'immobile non rientra tra quelle di piccola manutenzione a carico del
conduttore, perché i danni riportati dagli infissi, a meno che non siano
dipendenti da uso anormale dell'immobile, debbono presumersi dovuti al caso
fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore” (Corte
d’appello di Genova, Sez. I, sent. del 03/05/2021, n.453).
Va anche detto
che in ossequio al principio di autonomica contrattuale (art. 1322
c.c.) le parti possono sempre estendere il contenuto delle disposizioni sopra
elencate e quindi stabilire ex ante quali spese saranno in
carico al conduttore e quali al locatore, ma sempre nel rispetto delle linee
guida stabilite dalla normativa vigente: per esemplificare, sarebbe nulla la
clausola contrattuale che, in deroga agli artt.
1575-1576-1609 c.c., ponesse ad esclusivo carico del conduttore tutte le
spese di manutenzione dell’impianto elettrico comprese quelle di natura
straordinaria.
Un altro caso
pratico è la posa di una linea dedicata a grossi elettrodomestici che
necessitano di sopportare un consumo ed un voltaggio molto elevati: si pensi
all’installazione di una linea elettrica espressamente dedicata all’impianto di
climatizzazione non presente nell’appartamento, questo intervento resta a
carico del conduttore, salvo diversa pattuizione, perché non rientra tra gli
obblighi che la legge impone al proprietario.
In caso di danni causati dal malfunzionamento dell’impianto elettrico, chi
paga?
Anche in questo caso occorre distinguere caos per caso: se si tratta di
danni conseguenti ad un difetto di manutenzione per l’usura (che resta in
carico al conduttore), i relativi costi sono a carico dell’inquilino; mentre se
si tratta di carenze strutturali dell’impianto elettrico (che invece restano a
carico del locatore), sarà quest’ultimo a doversene fare carico.
A tale ultimo riguardo si segnala la seguente sentenza: “nell'ipotesi
di danni patiti dal conduttore della cosa locata, il diritto al risarcimento
sussiste su base contrattuale, e discende dall'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c., e in particolare il
suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata,
giusto il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui
appunto costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all'art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla
struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da
impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione
contrattuale o legale” (Cass. civ., Sez. III, sent. del
20/02/2024, n.4578).
(a
cura di Avv. Luca Conti)